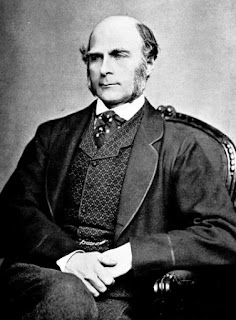L'anno 1994 segna il punto più alto
nella storia del calcio nigeriano. Le Super-Aquile della squadra dalla maglia verde e bianca come la bandiera nazionale, prima vincono
senza rivali la Coppa delle Nazioni Africane giocata in Tunisia tra
marzo e aprile, poi figurano brillantemente nella loro prima
partecipazione ai Campionati del Mondo giocati in Usa tra giugno e
luglio, dove escono agli ottavi di finale, eliminati fortunosamente
ai supplementari dall'Italia di Roberto Baggio, dopo aver dominato
gli azzurri per gran parte della partita.
Di quella squadre fanno parte molti
campioni già noti al pubblico europeo, o che si trasferiranno in
Europa subito dopo, come Amokachi, Amunike, Oliseh e altri; ma
l'indiscusso condottiero e trascinatore è il capitano, il veterano
Rashidi Yekini, che gioca in Portogallo, è il bomber del Vitoria
Setubal e, pur essendo il più anziano della squadra insieme al
portiere Rufai, è quello che si batte più di tutti, quello che non
si dà mai per vinto.
Yekini in azione contro l'Italia nel 1994
Yekini, un atleta alto oltre 190 cm e
largo come un armadio a due ante ma agile come un ballerino, dalla
devastante potenza fisica abbinata a una esemplare correttezza in
campo, entra nella storia del calcio mondiale il 21 giugno 1994:
quando, al 21' dell'incontro Nigeria-Bulgaria segna il primo gol
della sua nazionale ai Campionati del Mondo.
L'esultanza di Yekini dopo il gol alla Bulgaria nel 1994
In quell'edizione, non
troverà più la via della rete, ma sarà tra i migliori della sua
squadra in tutte le partite. Entra nel cuore non solo degli addetti
ai lavori, ma anche del pubblico meno esperto di gioco ma più
attento al lato umano dei campioni. Nessuno dimenticherà la sua
commossa esultanza dopo il gol alla Bulgaria o la compostezza con
cui, prima di ogni partita, si sofferma a pregare ai bordi del campo.
Yekini, musulmano osservante, non prega Allah per la vittoria, ma
perché vinca il migliore e nessuno si faccia male.
I Mondiali del 1994 sono però il canto
del cigno della sua carriera. Ha già 31 o 32 anni (come spesso
accade nei Paesi africani in cui gli uffici di anagrafe non
funzionano alla perfezione, dai documenti ufficiali risulta nato
nell'ottobre del 1963 a Kaduna, una città nella zona centrale della
Nigeria, ma da altre carte sembra che in realtà sia nato nell'agosto
del 1962) e, complici alcuni infortuni, non riesce più a ripetersi
ai livelli precedenti. In Nazionale viene ancora convocato
sporadicamente fino al 1998; poi si decide a lasciarla, amaramente,
dopo l'eliminazione di questa agli ottavi di finale (sconfitta per
4-1 dalla Danimarca) ai Mondiali di Francia del 1998.
Yekini in campo contro la Danimarca nel 1998
In quella
squadra, Yekini era ormai una riserva, e a volte il suo ingresso in
campo era accolto dai fischi del pubblico, compreso quello composto
dai tifosi nigeriani, che lo ritenevano ormai vecchio e superato. La
sua esperienza internazionale si chiude con 58 presenze e 37 gol, che
lo rendono il bomber indiscusso della Nigeria (dopo di lui, il primo
è Segun Odegbami, campione degli anni '70-'80, che ne ha segnati
23).
Continua però a giocare nelle squadre
di club: quando non c'è più possibilità di ottenere ingaggi in
Europa, va in Arabia Saudita e in Costa d'Avorio. Infine rientra in
patria. Appende definitivamente le scarpette al chiodo nel 2005.
Yekini dopo il ritiro dall'attività
Quando era giocatore famoso e stella
della Nazionale, Yekini si era costruito una fama di uomo esemplare,
noto in patria anche come filantropo. La Nigeria non è il miglior
Paese del mondo in cui vivere: un territorio enorme, uno Stato
federale con quasi 200 milioni di abitanti appartenenti a etnie molto
differenti tra loro, e infinite ricchezze naturali, ma tutto è in
mano alle multinazionali, che controllano e impongono sia i governi
sia le leggi, a spese della popolazione sfruttata e costretta a
vivere nel sottosviluppo. Il colonialismo, la cui criminale avidità
veniva già denunciata dal padre della letteratura nigeriana Chinua
Achebe negli anni '50, ha lasciato un'eredità devastante di odio,
violenza e sopraffazione. Negli anni '90, il dittatore Sani Abacha,
completamente asservito alle compagnie petrolifere, ha condannato a
morte lo scrittore Premio Nobel 1986 Wole Soyinka, poi rifugiatosi
negli Usa, e il poeta Ken Saro Wiwa, impiccato nel 1995 in quanto reo di "terrorismo" per essersi schierato dalla parte dei
movimenti ecologisti che manifestano per la tutela ambientale del delta del Niger, dove l'estrazione del petrolio sta distruggendo ogni ecosistema. Dieci anni dopo questa assurda esecuzione, scomparsi tutti i riferimenti dell'ecologismo pacifista, nella stessa area prenderà vita il Mend (Movimento per l'emancipazione del delta del Niger), un'organizzazione paramilitare che, sotto la bandiera della battaglia per la tutela dell'ambiente, compie ancora oggi ogni genere di atti di vero terrorismo.
In questa situazione, i conflitti etnici si acuiscono e i peggiori fanatismi trovano tutto lo spazio che vogliono: gli integralisti islamici, già molto prima di Al-Qaeda e dell'Isis, prendono di mira i cristiani (l'Islam è la religione di circa il 50% dei nigeriani, mentre i cristiani sono il 48% e il resto sono animisti, ma la distribuzione delle fedi non è uniforme, prevalgono i cristiani al Sud e i musulmani a Nord, e nelle aree i mezzo i conflitti sono violentissimi) con attentati che causano centinaia di morti. Le "imprese" della setta jihadista Boko Haram, fanatica e scissionista, trovano oggi ancora molta risonanza presso i mass media occidentali e non risparmiano nemmeno i calciatori, come Christian Obodo (ex di Udinese, Fiorentina e Lecce), rapito nel 2012 mentre si reca in chiesa e salvatosi solo perché riesce a fuggire prima di essere ucciso. Yekini, pur essendo musulmano, non ha nulla a che vedere con gli integralisti, da cui prende ripetutamente le distanze; e, anzi, tornato in patria non va a vivere nella natia Kaduna che è a maggioranza musulmana ma piena di integralisti violenti, ma in una piccola città, Irra, nello Stato di Kwara, a maggioranza cristiana, dove lui e la sua famiglia sembrano perfettamente integrati.
Chinua Achebe (1930-2013)
Wole Soyinka (1934)
Ken Saro Wiwa (1941-95)
In questa situazione, i conflitti etnici si acuiscono e i peggiori fanatismi trovano tutto lo spazio che vogliono: gli integralisti islamici, già molto prima di Al-Qaeda e dell'Isis, prendono di mira i cristiani (l'Islam è la religione di circa il 50% dei nigeriani, mentre i cristiani sono il 48% e il resto sono animisti, ma la distribuzione delle fedi non è uniforme, prevalgono i cristiani al Sud e i musulmani a Nord, e nelle aree i mezzo i conflitti sono violentissimi) con attentati che causano centinaia di morti. Le "imprese" della setta jihadista Boko Haram, fanatica e scissionista, trovano oggi ancora molta risonanza presso i mass media occidentali e non risparmiano nemmeno i calciatori, come Christian Obodo (ex di Udinese, Fiorentina e Lecce), rapito nel 2012 mentre si reca in chiesa e salvatosi solo perché riesce a fuggire prima di essere ucciso. Yekini, pur essendo musulmano, non ha nulla a che vedere con gli integralisti, da cui prende ripetutamente le distanze; e, anzi, tornato in patria non va a vivere nella natia Kaduna che è a maggioranza musulmana ma piena di integralisti violenti, ma in una piccola città, Irra, nello Stato di Kwara, a maggioranza cristiana, dove lui e la sua famiglia sembrano perfettamente integrati.
Poi succede qualcosa che non è stato
ancora chiarito e chissà se lo sarà mai. Yekini lascia l'ultima
moglie (ne ha avute 3) e i tre figli a Irra, dove vivono altri suoi
parenti tra cui la madre e uno zio che è un piccolo politico locale,
e si trasferisce a Ibadan, ancora più a Sud, la seconda città più
popolosa della Nigeria. Ci va, pare, per mettersi in affari con un
suo vecchio amico, Ibrahim, che di professione fa il gioielliere.
Sembra che investa tutti i suoi risparmi in questa attività, che
all'inizio sembra andare benissimo. Ma, intorno al 2008, qualcosa va
storto. Il negozio di Ibrahim subisce una rapina, Ibrahim viene
ucciso, tutta la sua merce e tutta la sua cassa spariscono. La
rapina, da subito, non appare un colpo improvvisato da una banda di
balordi ma l'opera di professionisti che sapevano benissimo cosa
cercare e dove. Non si saprà mai chi è stato: la legge, in Nigeria,
è spesso un optional.
Da un momento all'altro, Yekini si
ritrova a perdere tutto ciò che possedeva. Resta a Ibadan e conduce
una vita sempre più isolata. Si sente in pericolo, parla di
maledizioni che lo avrebbero colpito. Si lascia andare, al punto che
i testimoni (amici e vicini di casa) riferiscono di averlo visto
spesso in strada vestito come un barbone, a comprare cartocci di
pesce e piantaggine arrosto (un cibo tradizionale nigeriano) da
venditrici ambulanti, o a fare i propri bisogni nei cespugli.
Trapelano notizie per cui sarebbe affetto da depressione, disturbo
bipolare e altre patologie psichiche non meglio identificate. Ma
nessuno fa nulla, tanto meno le autorità, pure ripetutamente
sollecitate. La situazione precipita nel 2012, anche se le versioni
disponibili sui fatti sono tutte molto confuse. Si parla di parenti
che convincono Yekini a farsi curare da stregoni e altri santoni, di
pratiche che finiscono per debilitarlo ulteriormente e lo riducono in
uno stato pietoso, fino al ricovero in un ospedale di Ibadan, dove
però arriva in fin di vita e muore il 4 maggio 2012. Perfino a
questo punto, dal certificato di morte, non si capisce cosa ne abbia
provocato la fine.
Negli anni successivi, la madre di
Yekini denuncerà la totale indifferenza delle autorità al destino
del figlio; l'ex compagno di nazionale Sunday Oliseh stigmatizzerà
con rabbia l'ingratitudine di un popolo intero verso un grandissimo
atleta: ingratitudine di cui, dirà, Yekini era consapevole e per
questo pesantemente amareggiato. Ma, in tempi più recenti, la
polemica si è spinta ancora più avanti. Compaiono articoli di
giornale, post su blog indipendenti, video su YouTube che cercano di
ricostruire la vicenda e non ci riescono, perché ogni possibile
risposta lascia sempre aperti mille interrogativi. E si chiedono:
com'è potuto accadere? Perché nessuno ha fatto nulla quando era
possibile farlo? Cosa nascondono i tantissimi lati oscuri di questa
tragedia? In poche parole: perché Rashidi Yekini è morto?